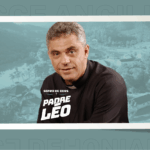Speranza, motore della vita consacrata e della missione al servizio degli altri
L’anno 2025 è stato dichiarato da Papa Francesco, di venerata memoria, un anno giubilare e il tema che deve guidare i fedeli durante questo anno è la speranza, una delle virtù teologali. In questo articolo ci proponiamo di riflettere sulla speranza come motore della vita consacrata e della missione al servizio degli altri. Inizieremo prima con un’illustrazione sulla virtù della speranza e il suo legame con le altre due virtù teologali, la fede e la carità, prima di mostrare come essa possa essere motore della vita consacrata e della missione delle persone consacrate.
La speranza e le altre virtù teologali
La speranza è la seconda virtù teologale dopo la fede. Le virtù teologali sono tre: fede, speranza e carità. Affermiamo la virtù della speranza nell’atto di speranza che recitiamo nelle nostre preghiere:
«Dio mio, spero fermamente
che per i meriti di Gesù Cristo,
Tu mi concederai la grazia in questo mondo e
la felicità eterna nell’altro,
perché Tu l’hai promessa e mantieni sempre
le Tue promesse.
Amen.»
La speranza è quindi una disposizione del credente che consiste nell’avere fiducia nella realizzazione delle promesse di Dio in questa vita presente e in quella futura. La speranza comprende attesa, fiducia e pazienza. Il compimento delle promesse non è conosciuto chiaramente dal credente, né il momento né il modo. Ma il credente si affida alla fiducia in Dio con la ferma convinzione dell’ottenimento dell’oggetto della promessa. Non sempre si ha chiarezza sul compimento di queste promesse, perciò si tratta più di affidarsi a Dio e contare solo sulla relazione che Egli desidera instaurare tra il credente e Lui. L’attesa non è necessariamente di ordine temporale ma più escatologica. Cristo ci insegna a vivere nell’attesa e nella speranza della manifestazione della gloria che Dio ha riservato a ciascuno di noi in questa vita ma soprattutto nel compimento dei tempi. La speranza ci fa desiderare e attendere la vita eterna in Dio. Rinforza la nostra fiducia nelle promesse di Dio, contando solo sul nostro Signore Gesù Cristo e sulla grazia dello Spirito Santo. Per mantenere costante la speranza, è necessario armarsi della virtù della perseveranza nell’attesa, che consolida e sostiene la pazienza.
Ciò che caratterizza la speranza cristiana è che la vita non finisce nel nulla. La vita cristiana è un cammino che ha bisogno di momenti forti per nutrirsi di speranza. «Mettersi in cammino è la caratteristica di chi cerca il senso della vita.»
Va però detto che l’attesa non è passività o ozio. Parliamo della relazione tra speranza e fede cristiana da una parte, speranza e carità dall’altra, prima di vedere come dovremmo, come consacrati, vivere e diffondere questa virtù della speranza.
1.1 Speranza e fede cristiana
La vita cristiana è un pellegrinaggio nella fede guidato dalla speranza. La speranza non è ottimismo né positivismo, ma frutto di una ferma credenza nutrita dalla Parola di Dio, che influisce sul nostro atteggiamento verso gli eventi quotidiani, i doveri di carità e di tolleranza radicati nella trasformazione della nostra umanità secondo il progetto di Dio. La nostra fede è sempre un cammino, un pellegrinaggio verso il compimento dei tempi, cioè la parusia o il ritorno di Cristo per il giudizio universale. L’epistola agli Ebrei descrive la fede come «il possesso di ciò che si spera, la prova di realtà che non si vedono» (Eb 11,1). L’epistola continua mostrando come la speranza sia stata il motore della fede e della missione dei nostri antenati nella fede: Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Sansone, Iefte… (Eb 11, 1-40). Essi sopportarono grandi prove e trionfarono grazie alla virtù della speranza. Non videro essi stessi la realizzazione dell’oggetto della loro speranza nella loro vita, ma la fiducia in questa realizzazione fu il motivo della loro perseveranza nell’attesa. La speranza è l’arma che aiuta il credente a vincere la paura e a sopportare prove dolorose. Permette di affrontare le vicissitudini della vita presente, per quanto difficili siano. San Paolo incoraggia i fedeli di Tessalonica con queste parole: «Non vogliate essere tristi come gli altri che non hanno speranza» (1 Ts 4,13). Se la speranza venisse a mancare, la fede e la vita cristiana perderebbero significato. I cristiani non potrebbero essere né sale della terra né lievito nella pasta. Sarebbero trama di ideologie, canne piegate al vento (Sal 1,4). In questo senso la speranza anima e vivifica la fede.
Il nostro credo niceno-costantinopolitano è trinitario, cioè confessa le tre persone in un solo Dio e può essere diviso in tre parti: la questione di Dio (creazione e trascendenza), la questione cristologica (incarnazione e redenzione), la questione dello Spirito Santo che vivifica la Chiesa e i credenti. Quest’ultima parte si conclude con la formulazione della speranza cristiana: «Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.» Questa vita del mondo che verrà il credente non la conosce nei dettagli, ma ha la certezza che il futuro non porta al vuoto o al nulla. Questa certezza aiuta a dare senso alla vita presente perché si apre al futuro. Crescere nella fede e nella nostra vocazione missionaria nel mondo presente aiuta a fronteggiare le vicissitudini quotidiane e a giustificare i nostri sforzi in questo viaggio che ci conduce verso l’orizzonte futuro che speriamo. Questa fede nella vita futura ha aiutato i cristiani della Chiesa primitiva a sopportare persecuzioni, tribolazioni e persino la morte. Così la speranza motiva altre virtù come il coraggio, la forza e la temperanza, che a loro volta permettono al credente di superarsi sempre nella sua situazione presente per proiettarsi nel futuro e nell’escatologia.
Inoltre la speranza fa parte della natura degli esseri creati a immagine e somiglianza di Dio (Ef 1,3-5); san Tommaso d’Aquino descrive la fede come la sostanza delle cose che si sperano, la disposizione stabile dello spirito attraverso la quale la vita eterna prende radice in noi. La fede contiene le cose per cui speriamo; ci aiuta a realizzare ciò che ancora è invisibile e la speranza ci conduce alla certezza che, per grazia di Dio, si compirà. La speranza ci fa vedere il trionfo alla fine delle nostre pene e ci sprona a fare maggiori sforzi per il raggiungimento di ciò che inseguiamo.
La fede conduce necessariamente alla speranza. La speranza è l’attesa del compimento delle promesse di Dio. Credere significa abbandonarsi come Abramo a Dio in un’avventura senza sicurezza, basandosi solo sulla fiducia nella Sua Parola. È la speranza della nostra salvezza definitiva, garante dei beni che speriamo, prova delle realtà che non vediamo (Eb 11,1). L’impegno straordinario dei primi cristiani era sostenuto dalla fede nella venuta imminente di Cristo (1 Ts 5,2). Essa stimolava in loro vigilanza e determinazione per affrontare situazioni difficili (Rm 13,11-14). Questa certezza costituisce uno stimolo a mettersi al servizio e un’ancora sicura e solida che mantiene fermi nell’impegno. Quando i fedeli perdono o si allontanano dalla fede o dalla speranza nel compimento delle promesse di Dio, non si impegnano più nella trasformazione del mondo o, meglio, non si dedicano più all’evangelizzazione. Si potrebbe quindi dire che la speranza è una forza che dinamizza la fede e l’impegno del credente.
1.2 Speranza e carità
La Costituzione pastorale Gaudium et spes afferma nel suo preambolo: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di questo tempo, specialmente dei poveri e di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e non c’è nulla di veramente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, si edifica con uomini, riuniti in Cristo, guidati dallo Spirito Santo nel loro cammino verso il Regno del Padre, e portatori di un messaggio di salvezza che deve essere proposto a tutti. La comunità dei cristiani si riconosce quindi veramente e intimamente solidale con il genere umano e la sua storia.»
La speranza sostiene l’impegno cristiano ad amare di più e a fare il bene sopportando anche le sofferenze e le avversità, lavorando con determinazione per la propria salvezza e quella dei fratelli e sorelle. La speranza mobilita le energie per la trasformazione del mondo attraverso la fecondità dei talenti o dei carismi che lo Spirito Santo ha posto in noi. Riguardo alla parabola dei talenti, il terzo beneficiario non ha fatto fruttare il suo talento perché non aveva speranza, a differenza dei primi due che speravano innanzitutto che il talento potesse produrre e anche che i frutti fossero benefici per il loro padrone (Mt 25,24-25).
La speranza libera dalla paura ma anche dall’egocentrismo e apre alla generosità verso Dio e verso il prossimo. In questo senso, san Paolo si rivolge ai cristiani di Roma: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire voi stessi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma rinnovatevi nello spirito della vostra mente, per discernere qual è la volontà di Dio, ciò che è buono, ciò che è gradito e perfetto.» (Rm 12,1).
La speranza apre alla costruzione di un futuro migliore. Infatti, il messaggio cristiano non è solo informativo ma anche performativo. Chiama a produrre fatti nella vita quotidiana. Chiama i cristiani ad anticipare il regno di Dio.
2. La speranza nel cuore della vita consacrata
Le nostre congregazioni religiose sono la realizzazione dell’utopia dei loro fondatori. L’ideale delle fondazioni è portato dal desiderio di essere più vicini a Dio, di amarlo e servirlo maggiormente. L’ideale è una tensione verso la perfezione, la vita beata. La vita consacrata nasce spesso da crisi nella Chiesa o nella società e i fondatori degli ordini, sviluppando una spiritualità o un ideale di vita, vogliono aprire una breccia per uscire dalla crisi. Sono allora portatori di speranza per la Chiesa e la società del loro tempo. La vita consacrata è sin dalle origini un appello a vivere la radicalità evangelica per risvegliare la coscienza degli uomini a lavorare per avvicinarsi a Dio. È sempre una ricerca di perfezione o santità, che è già qui e non ancora. Quando rivediamo la fondazione dei nostri ordini, scopriamo che i fondatori sono stati tutti avventurieri che talvolta navigavano a vista; a volte furono tentati di abbandonare il progetto o di cadere nello scoraggiamento, ma è stata necessaria la virtù della speranza perché continuassero a perseguire il loro ideale. Come esercizio, ciascuno può tornare alla fondazione del proprio ordine e riconoscere i momenti di scoraggiamento e incertezza e anche come i nostri fondatori abbiano ritrovato la speranza per aggrapparsi ad essa e continuare le loro opere.
I loro discepoli, noi, aderendo ai loro ideali, cerchiamo anche una santità di vita. La santità è una questione di speranza. La si persegue attraverso una conversione permanente. La speranza attrae la forza per il rinnovamento personale e quello della Chiesa. Se ripercorriamo la storia delle nostre vocazioni – e dobbiamo farlo sempre – ci renderemo conto che i momenti in cui siamo stati più deboli sono stati quelli in cui eravamo in crisi di speranza.
La speranza è frutto di una forte credenza nutrita dalla Parola di Dio nella Bibbia, implementata nei nostri atteggiamenti negli eventi quotidiani, nei fatti e atti di carità, nella tolleranza verso gli altri. È la motivazione che ci mantiene attaccati alla nostra missione di essere creativi nelle risposte alle difficoltà e alle sfide, e di continuare a scoprire la strada anche nella nebbia che offusca il futuro. È la luce che illumina i nostri momenti bui e ci mantiene saldi nel cammino verso la meta ultima, facendoci anche luce per coloro che sono affidati alla nostra missione, per guidarli sulla via della salvezza.
Noi religiosi e religiose abbiamo la missione di forgiare il destino dei popoli che vivono situazioni disperate. In realtà è riprodurre la missione di Cristo che leggiamo nel Vangelo, che consiste nel rendere credibile questo Vangelo vivendolo e liberando uomini e donne da diverse schiavitù. Come ci impegniamo in questa missione di dare speranza ai popoli disperati?
3. Missione della speranza nell’annuncio e nella testimonianza
I religiosi, come ogni cristiano, sono chiamati ad essere sale, luce e lievito ovunque si trovino. Dare testimonianza della loro fede richiede che non siano un peso per sé stessi o per la società, ma piuttosto seminatori di speranza consapevoli della loro missione di far gustare al mondo, illuminarlo con la luce del Vangelo e trasformarlo in un ricettacolo di virtù.
Come i nostri fondatori e fondatrici, siamo chiamati a scrutare i segni dei tempi che il Signore ci offre per rispondere in modo adeguato alle sfide nella nostra Chiesa e nelle nostre società. I nostri carismi e spiritualità sono vari e forse il contesto di oggi è diverso da quello dei fondatori, ma dobbiamo sempre cercare di rinnovarli affinché, vivendo essi, siamo portatori di speranza ai nostri contemporanei.
Abbiamo congregazioni fondate su un’opera specifica per rispondere a un bisogno della società o della Chiesa, ma oggi quel bisogno non esiste più. L’opera morirà? No, perché il carisma o la spiritualità richiede sempre una reinterpretazione e un adattamento ai tempi. L’opera della Mercede, fondata nel XII secolo per il riscatto degli schiavi, è sopravvissuta anche quando la schiavitù classica era quasi finita. L’ordine oggi riflette sulle schiavitù moderne e cerca come liberare o alleviare chi ne è vittima. I membri lavorano ora con i rifugiati, non solo per fornire loro mezzi o soluzioni ai problemi basilari (nutrirsi, vestirsi, trovare un alloggio) ma anche per la loro integrazione nella società ospitante, aiutandoli a regolarizzare la loro situazione, a trovare un lavoro dignitoso senza troppe difficoltà. Facendo questo, Fratelli e Padri sono missionari della speranza presso i rifugiati. A questo proposito, San Giovanni Paolo II ci esorta in Vita consecrata: «Non avete solo da ricordare e raccontare una storia gloriosa, ma dovete costruire una grande storia! Guardate al futuro, dove lo Spirito vi manda a fare grandi cose.»
Una dimensione della vita consacrata che può aiutare religiosi e religiose a coltivare la speranza del popolo è la dimensione profetica. I religiosi, con il loro stile di vita e la loro predicazione, lottano contro ciò che disumanizza per ridare coraggio a uomini e donne senza speranza. Sono chiamati a seguire Cristo nel liberare uomini e donne dalle diverse schiavitù degli idoli (ricchezza, sesso, potere). Siamo invitati a imitare Cristo nel vivere questa dimensione profetica assumendo la sua missione. Gesù è il profeta per eccellenza. All’inizio del suo ministero pubblico, si appropria della lettura in sinagoga a Nazaret, Is 61,1-2: «Lo Spirito del Signore è su di me: mi ha consacrato per portare ai poveri una buona notizia. Mi ha mandato a proclamare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, a liberare gli oppressi e a proclamare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Pur non avendo nulla contro la ricchezza, avendo amici ricchi come Giuseppe di Arimatea e frequentando anche Zaccheo, ne desacralizza l’uso. Si eleva contro la dittatura dei beni che schiavizza gli uomini, riduce
4. Alcuni luoghi fecondi per la semina della speranza
- Ambiente educativo. Il saggio Confucio diceva: «Se il tuo piano è per un anno, pianta il riso. Se il tuo piano è per dieci anni, pianta gli alberi. Ma se il tuo piano è per cento anni, educa i bambini.» I religiosi sono educatori di coscienza e l’educazione è un fattore di speranza. Attraverso essa aiutano i popoli a far fronte alla loro situazione presente e futura. Siamo invitati a inventare pedagogie portatrici di speranza nelle nostre scuole, nei nostri conventi, nei nostri apostolati. I nostri giovani, sebbene formati, non riescono a prendersi cura di sé. Non possiamo attribuire solo alla congiuntura la colpa senza interrogarci se i nostri metodi di formazione diano davvero speranza. Certo, ci si sforza di formare qualità nelle nostre scuole, ma, come i religiosi Angèle de Medecis, Don Bosco, dobbiamo inventare pedagogie preventive e curative per aiutare la nostra gioventù e i nostri popoli a imparare a essere anche inventivi e creativi. Per questo il Papa ci invita a lavorare nel mondo giovanile. Scrive: «È triste vedere giovani senza speranza. Quando il futuro è incerto e impermeabile ai sogni, quando gli studi non offrono sbocchi e la mancanza di lavoro o di un impiego sufficientemente stabile rischia di annientare i desideri; è inevitabile che il presente venga vissuto nella malinconia e nella noia. L’illusione delle droghe, il rischio della trasgressione e la ricerca dell’effimero creano, più in loro che in altri, confusione e nascondono la bellezza e il senso della vita, facendoli scivolare in abissi oscuri e spingendoli a compiere gesti autodistruttivi. È per questo che il Giubileo deve essere nella Chiesa l’occasione di un impulso verso di loro. Con passione rinnovata, prendiamoci cura dei giovani, degli studenti, dei fidanzati, delle giovani generazioni! Vicinanza ai giovani, gioia e speranza della Chiesa e del mondo!»
- Il dialogo. I religiosi devono aprire la strada al dialogo tra i popoli di diverse culture, religioni, età e condizioni sociali. Il dialogo promuove l’unità nella diversità e dà credito alla loro testimonianza. Nel dialogo, i religiosi non offrono solo agli altri, ma ricevono anche dagli altri e valorizzano ciò che ricevono da loro. I monaci sono stati a lungo agenti di sviluppo dell’agricoltura e persino delle scienze profane. Alla caduta dell’impero romano, furono loro a salvare il patrimonio artistico-letterario del mondo antico dalla distruzione dei barbari e a conquistare le foreste per portare i popoli ad imparare a formarsi e a prendersi cura di sé attraverso la valorizzazione delle terre. Non si limitarono a conservare il patrimonio dell’antichità, ma lo svilupparono e lo valorizzarono per dare speranza ai giovani e agli uomini assetati di sapere. I religiosi non devono fuggire o restare indietro nella padronanza degli strumenti informatici oggi in voga. Sono chiamati a umanizzare l’intelligenza artificiale ed essere persino all’avanguardia di altri nuovi mezzi di comunicazione.
- I religiosi hanno la missione di mantenere viva la fiamma della speranza nella Chiesa e nel mondo attraverso il loro stile di vita, il loro coraggio e la loro devozione. La loro vita comunitaria e la fraternità che ne deriva producono la testimonianza che è possibile vivere in pace e in armonia con persone diverse per lingua, cultura, gusti, età, condizioni sociali… La loro vita comune suscita vocazioni, cioè attrae giovani che cercano un futuro. La mancanza di vocazioni è segno che i religiosi non creano più, né individualmente né comunitariamente, speranza per i giovani.
Conclusione
Bisogna credere che le nostre vite sono sempre portatrici della missione di speranza verso gli altri, anche a nostra insaputa. Concludo con una storia che ho seguito in un video sui social network. La riassumo così: i giorni migliori della nostra vita sono a volte quelli che abbiamo creduto essere i peggiori o i giorni in cui ci sono mancati i motivi per sperare.
Una domenica sera, un sacerdote arriva in chiesa per celebrare la Messa come aveva l’abitudine. All’orario consueto della Messa, non c’è nessuno. Attende e dopo circa 15 minuti entrano tre bambini e prendono posto in chiesa. Dopo altri 10 minuti, entrano a loro volta due adolescenti. Decide di iniziare la Messa con queste cinque persone. Durante la Messa, entra una coppia e si siede in fondo alla chiesa. Durante l’omelia, entra un uomo sporco con delle corde in mano. Il sacerdote non capisce perché la gente del luogo sia diventata così poco impegnata, ma non si lascia scoraggiare dalla delusione. Predica con zelo e devozione. Sulla strada di casa viene aggredito da due banditi che gli strappano tutto ciò che aveva con sé, compreso il suo baule sacro. Tornato a casa, fascia le ferite, fa il bilancio della giornata e dichiara: «Questa è stata la peggior giornata della mia vita, il giorno in cui ho sperimentato il fallimento del mio ministero, il giorno infruttuoso della mia carriera, ma non importa! Ho provato tutto per il Signore.»
Dopo sette anni, il sacerdote, predicando nella stessa chiesa, torna su quel triste giorno. Quando finisce l’omelia, una coppia lo ferma e gli dice: «Padre, la coppia che era entrata quando la Messa era iniziata eravamo noi. Eravamo sul punto di divorziare a causa di molti litigi e problemi in famiglia. Ci siamo detti, prima di separarci, andiamo un’ultima volta in chiesa come avevamo l’abitudine. Ma la sua omelia ci ha scosso nel profondo al punto che abbiamo creduto che stesse predicando solo per noi. Tornando a casa quella notte, abbiamo iniziato a minimizzare i nostri problemi e litigi e oggi formiamo una famiglia sempre unita.»
Dopo l’intervento della coppia, un noto imprenditore che ha aiutato molti poveri della zona e ha contribuito molto alla ristrutturazione della chiesa chiede la parola. «Padre, dice, sono l’uomo sporco che è entrato con le corde in mano. Avevo fatto bancarotta e mi ero lanciato nell’alcol e nella droga. Mia moglie e i miei figli mi avevano abbandonato a causa del mio comportamento. Quel giorno avevo comprato una corda per suicidarmi e quando me la sono messa al collo, si è rotta e sono andato a comprarne altre più robuste. Ma passando di qui, ho visto la chiesa aperta e ho pensato di distrarmi un po’ entrando. La sua omelia mi ha trafitto il cuore e tornato a casa ho cambiato idea e ho iniziato a lavorare per abbandonare alcol e droga. Ho iniziato a impegnarmi nel lavoro e oggi mia moglie e i miei figli sono tornati a casa e formiamo una famiglia felice. Sono uno dei grandi imprenditori della città.»
Alla porta della sacrestia, il diacono dichiara: «Padre, sono uno dei banditi che la sera in cui lei è stato aggredito le ha portato via tutto ciò che aveva. Il mio compagno è stato ucciso mentre preparavamo la prossima rapina dopo di lei. Quando ho rotto il suo baule sacro, ho visto la sua Bibbia e ho iniziato a leggerla di tanto in tanto. Ho preso gusto ad ascoltare la parola di Dio e a frequentare questa chiesa. Ed è così che ho scoperto la mia vocazione e sono entrato in seminario.»
Alla fine il sacerdote si mise a piangere e i fedeli lo seguirono nelle lacrime. Ma erano lacrime di gioia derivanti dalla scoperta che i giorni che crediamo i peggiori della nostra vita sono a volte quelli in cui Dio compie i suoi miracoli più grandi. Da ciò, non bisogna mai perdere la speranza in nessuna circostanza, per quanto dolorosa possa essere. Il Signore è sempre con noi.
Questo per dire di non scoraggiarci mai, anche quando subiamo il martirio, di credere che siamo sempre in missione e portatori di speranza, strumenti della realizzazione dei disegni di Dio per salvare l’umanità che a volte manca di speranza.